Il 27 Gennaio. Tra storia e memoria.
- Andrea Chicca
- 18 feb 2016
- Tempo di lettura: 9 min
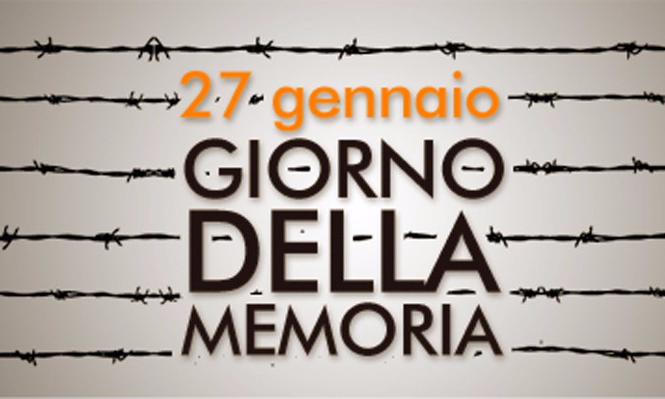
Il 27 gennaio. Tra storia e memoria.
Mi sono sempre chiesto cosa significhi ricordare, che cosa voglia dire “Non dimenticare”. E come si possa dimenticare una cosa che non abbiamo mai vissuto.
In concreto: cosa ricordiamo e che cosa resta del giorno della memoria?
I rappresentanti di istituto hanno scelto per questa occasione di proiettare il film di Margarethe Von Trotta, Hannah Arendt, che riguarda l'accoglienza delle corrispondenze della filosofa dal processo Eichmann (raccolte e rielaborate poi ne La banalità del male).
Non sono stato presente alla proiezione e me ne rammarico: ero invece a Firenze ad assistere alle celebrazioni al Mandela Forum. La cerimonia ha visto almeno ottomilacinquecento studenti di tutte le scuole superiori toscane ascoltare dalla voce dei testimoni le atrocità compiute dai tedeschi nella II guerra mondiale. Ho pensato ai due avvenimenti così diversi e a elaborare uno scritto che mettesse in chiaro i punti in comune nascosti tra la Arendt, il processo Eichmann e le celebrazioni al Mandela Forum.
Partiamo dall'inizio, ovvero dalla Arendt: l'analisi del totalitarismo da parte dell’ebrea tedesca che è dovuta fuggire dalla sua patria e riparare in America ha prodotto il monumentale Le origini del totalitarismo, ma anche La banalità del male, opera che ha suscitato molte critiche al momento della sua stesura.
E' interessante notare che nel libro si delinea la personalità di un burocrate dello sterminio, una persona che avrebbe diretto i treni per le deportazioni con la stessa efficienza di un trasporto di mozzarelle e che, se non fosse stato agli ordini di un regime criminale, avrebbe svolto un qualsiasi mestiere rispettabile all’interno della società. La Arendt non si trova quindi di fronte a un mostro, ma un ometto dimesso, calvo e con gli occhiali, quasi comico nel suo alzarsi e abbassarsi all'entrata della corte per rispetto all'autorità, da qualsiasi parte venga. L’annullamento delle scelte etiche nel regime nazista è tale che “il libero consenso per il dominio totale è un ostacolo altrettanto grande della libera opposizione [1]”.
Oggi la storiografia ha contestato questa ricostruzione. Sono uscite biografie di Eichmann che ricostruiscono un'immagine di razzista consapevole e fanatico, ma le categorie interpretative della Arendt, anche se non applicabili al singolo caso, mantengono comunque la loro validità. Proprio a causa del processo Eichmann e dello scalpore che suscitò nel mondo, lo psicologo Stanley Milgram inventò l’esperimento sull’obbedienza all’autorità che lo rese celebre: Milgram, in divisa da scienziato, ha ordinato un campione di volontari di somministrare scariche elettriche di intensità crescente (fino a 450 volt) a una vittima. L’80% degli intervistati, nonostante lo scienziato non operasse alcuna costrizione, è arrivato fino al massimo del voltaggio.[2]
L’altra accusa contenuta nel libro della Arendt è quella alla comunità ebraica, o meglio, ai suoi capi che non si ribellarono alle persecuzioni, collaborando con il nemico che voleva annientarli. L’esperimento di Milgram, in questo caso fornisce una chiave di lettura interessante: l’uomo è naturalmente portato ad obbedire all’autorità, poiché - in caso contrario - non sarebbe possibile la vita sociale. Questo istinto gregario porta però, in determinati casi, a rendere la distinzione tra bene e male piuttosto labile, ancor di più nel caso di guerra combattuta con una mobilitazione totale, sia materiale che propagandistica. I capi delle comunità ebraiche pensarono, in buona fede, di obbedire evitando danni peggiori alla loro popolazione e di ritardare così il momento della deportazione e dell’esecuzione. Primo Levi ne I sommersi e i salvati parla della “zona grigia”, ovvero di coloro che collaborarono con i nazisti per vantaggi personali o perché convinti di fare il meglio per il loro popolo. La demarcazione tra buoni e cattivi, tra il bianco e il nero, è difficile perché questi agenti del nemico condivisero il destino finale del popolo ebraico. Due esempi tragici valgono a trovare conferma delle affermazioni di Levi, Adam Czerniakow e Chaim Rumkovski, i capi dei due ghetti più importanti: Varsavia e Lodz. Czerniakow, capo del ghetto di Varsavia, si suicidò quando capì di essere un mero strumento dello sterminio del suo popolo; Rumkowski, una sorta di Quisling [3] ebraico, che governò con pugno di ferro il ghetto di Lodz fino alla sua liquidazione nel 1944, è biasimato tutt'ora dal suo popolo, e addirittura per la sua deportazione pretese dai tedeschi un vagone solo per sé e la sua famiglia ( finì ugualmente come gli altri in una camera a gas). Avendo trasformato la città in un opificio al servizio del nemico, ne aveva rimandato la distruzione, permettendo a qualcuno di sopravvivere fino all’arrivo dell’armata Rossa. Anche il capo del ghetto di Lodz è quindi da annoverarsi in quella zona grigia, al limite del nero, che sta tra vittime e carnefici; Levi stesso ha compreso, nel capitolo sulla vergogna di sopravvivere, che i testimoni, i salvati, hanno sempre una memoria imperfetta delle condizioni del campo perché, per la maggior parte, hanno avuto questo destino grazie alla collaborazione con gli aguzzini (Levi lavorava nel laboratorio chimico del campo).[4] I veri testimoni, quelli più attendibili sono infatti i sommersi, i morti, i “mussulmani”[5]: per questo motivo vergogna e paura di non essere creduti albergarono tra i sopravvissuti, tanto che subito dopo la guerra quasi nessuno fece parola dell’esperienza del campo.
Lungi dall’essere una storia completa della distruzione degli ebrei d’Europa queste sono solo alcune delle riflessioni che possono suscitare il processo Eichmann e l’analisi della Arendt. A ben vedere il processo ha notevole influenza sul modo di ricordare la Shoah.
La filosofa si accorse inoltre di un progetto politico sotteso al dibattimento e denunciò che Ben Gurion, il primo ministro di Israele, voleva fondare la legittimità dello stato ebraico su questo processo e così fornire una giustificazione alla contrastata nascita della nazione. Con il processo Eichmann la Shoah diventa parte della memoria collettiva di Israele e il testimone si impone come veicolo privilegiato per gli eventi luttuosi del ‘900.
La Arendt, con grande chiarezza, sembra essere una delle poche ad accorgersi di questo iato tra ciò che si vuole colpire e l’uomo alla sbarra: “Malgrado le intenzioni di Ben Gurion [che aveva inteso, con questo processo, colpire l’antisemitismo in tutta la sua storia] e gli sforzi del pubblico ministero, al banco degli imputati c’era sempre un individuo, una persona in carne ed ossa.[6]”
Le testimonianze che si susseguono al processo sono di persone che hanno subito sulla loro pelle gli orrori della deportazione e che, però, hanno poco a che fare con l’accertamento della colpevolezza dell’imputato. Lo scopo politico del processo è mostrare ai giovani israeliani e al mondo intero, la verità storica. In Israele, poco dopo la fondazione e fino al processo Eichmann, il genocidio era infatti ignorato per una precisa scelta della classe dirigente. Dal genocidio non era possibile trarre alcuna lezione l’israeliano è un “ebreo nuovo”, la cui mentalità deve rompere radicalmente con quella di sottomissione […] propria a coloro che “si sono lasciati condurre come pecore al macello.[7]
La creazione di una memoria storica che fa degli israeliani gli scampati alla Shoah inizia proprio con il processo Eichmann e il mezzo con cui viene raggiunto questo obiettivo è proprio la testimonianza: a Norimberga un poeta ebreo chiese di testimoniare in Yiddish, la lingua della sua comunità, ma non gli fu concesso in quanto non era tra le lingue ammesse; al processo Eichmann, invece, fu concesso (nonostante lo Yiddish non fosse tra le lingue ufficiali dello stato ebraico). La testimonianza offre così l'immagine storica di un evento e solo in secondo luogo diventa utile al dibattimento: in questo modo la Shoah diviene conoscibile in via privilegiata grazie alla memoria dei testimoni, la quale diviene così spiegazione storica autosufficiente. Durante le celebrazioni a Firenze la presenza di uno storico, Tommaso Detti, brillava proprio per la sua inutilità: egli ha presentato la manifestazione, una esecuzione musicale e il presentatore, Gad Lerner, senza fornire coordinate a studenti che ignoravano la cornice nella quale si sono svolti i fatti narrati.
Il giorno della memoria ha come momento fondante la testimonianza e il pensiero che essa sia autosufficiente senza una spiegazione storica. La mia formazione di storico mi impone di separare i momenti di ricerca e scrittura dal giudizio personale su un avvenimento. Il paradigma che il procuratore generale Gideon Hausner cerca di imporre ad Israele e al mondo è quello di una storia che per questo evento ha come unica soluzione quella di essere la somma dei dolori della vittime, che deve rompere con la freddezza del mestiere di storico e restituire l'orrore.[8]
La memoria e la storia, come fenomeni che attengono tutti e due agli uomini nel tempo, hanno punti in comune, ma spesso risultano anche inconciliabili. Paul Ricoeur nel suo La memoria, la storia l’oblio esamina il loro rapporto e conclude che la storia può contraddire la memoria ed avere con essa ha un rapporto duplice di veleno e di cura[9]. Molti testimoni, pur in buona fede, ricordano i volantini affissi dai tedeschi che intimavano ai responsabili dell’attentato di Via Rasella di consegnarsi pena rappresaglie sulla popolazione civile. In realtà il testo del messaggio si concludeva con un laconico “L’ordine è già stato eseguito”.[10] La ricerca sugli archivi e sui testi in questo caso stride con la verità di chi è stato presente.
La scrittura della storia, accusatae di freddezza dal procuratore generale di Israele Gideon Hausner, cozza con la viva memoria; per Ricoeur tra la scrittura meditata fatta sulla ricerca d’archivio e la parola viva c’è una vera e propria frattura epistemologica.
Ciò che manca alle celebrazioni pubbliche, che a volte assumono il segno di un rituale stanco, è proprio la conoscenza della frattura tra storia e memoria, tra la parola viva che emoziona e la scrittura meditata di relazioni e rapporti di potere, di sopraffazione, economici, psicologici. La storia della Shoah, che si impone come un evento senza uguale nella modernità, nelle celebrazioni pubbliche è la storia delle vittime, la somma dei racconti di sei milioni di morti costituisce la verità definitiva, senza la necessaria frattura che porta la scrittura storiografica.
L’obiezione che si può fare a questo discorso è che la freddezza, la meditazione, la comprensione siano una seconda uccisione delle vittime, che hanno bisogno di pietà e rispetto.
Ho sempre pensato che la pietà e il rispetto, la tolleranza e l’assenza di razzismo debbano essere la bussola, ma proprio per questo penso che sia possibile celebrare il giorno della memoria tra i due poli del discorso: l’emozione della parola e la comprensione di meccanismi profondi che portano così le giovani generazioni a stare in guardia con il cuore e la testa per far sì che risuoni l’imperativo al quale tende l’umanità:“Mai più!”.
[1] Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2004, p. 617.
[2] L’esperimento, spiegato più ampiamente consisteva in questo: si reclutavano, tramite un’inserzione nei giornali locali, volontari per una sperimentazione sulle punizioni nell’apprendimento.
Al volontario veniva sempre assegnato il ruolo dell’insegnante, mentre quello dell’allievo andava a un collaboratore degli sperimentatori.
L’insegnante doveva porre dei quesiti all’allievo e somministragli una scarica elettrica graduata se questi sbagliava. Ad ogni errore il voltaggio aumentava di 15 volt, da un minimo di 15 a un massimo di 450.
Il generatore era finto, ma la “vittima”, raggiunto un certo voltaggio, intimava di smettere o, per gli ultimi voltaggi, non emetteva più alcun suono; naturalmente lo scopo dell’esperimento non era quello di vedere come le punizioni influenzassero l’apprendimento, ma di testare fino a quanto l’obbedienza a un’autorità (lo sperimentatore) potesse spingere una persona a provocare dolore agli altri. Il risultato colpì persino gli stessi sperimentatori: l’80% delle persone obbedì, sia pur a malincuore e con proteste, all’ordine dell’autorità fino al voltaggio massimo.
Milgram spiegò questo risultato con l’influenza che l’autorità aveva esercitato sui volontari, tramite precise
prescrizioni impartite.L’oobedienza all’autorità è alla base delle motivazioni che spinsero i tedeschi “comuni” allo sterminio secondo lo storico inglese Christopher Browning. Cfr C. Browining, Uomini comuni.Polizia tedesca e soluzione finale in Polonia, Einaudi, Torino 2004.
[3] Vikdun Quisling (18871945) fu il capo dei fascisti norvegesi, appoggiò l’invasione nazista per costituire nel paese un governo fantoccio agli ordini della Germania. Da quel momento il suo nome è sinonimo di collaborazionista.
Venne fucilato nel 1945.
[4] La commovente vicenda di un prigioniero ebraico e la sua capacità di arrangiarsi è raccontata nel fumetto Maus di Art Spiegelmann, in cui l'autore parla del padre, sopravvissuto ad Auschwitz.
[5] L’origine del termine è incerta, ma musulmani erano quei detenuti che, avendo perso ogni speranza, aspettavano solo la morte. Di essi se ne sono salvati pochissimi.
[6] H. Arendt, La Banalità del male. Eichmann a Gerusalemme in A. Wieworka, L’era del testimone, Raffaello
Cortina, Milano 1999, p101.
[7] A. Wieworka, L’era del testimone, p. 83
[8] Sul comprendere e non giudicare cfr M. Bloch, Apologia della storia o il mestiere di storico, Einaudi, Torino 1950, sull'uso della testimonianza in ambito giuridico e storico A. Wieworka, op. cit.; l'interessante resoconto di C. Browning su un campo di lavoro in Polonia e il processo ai responsabili della sua liquidazione e sull'uso che delle testimonianze orali possono fare il giudice e lo storico, C. Browning, Lo storico e il testimone, Laterza, Bari 2011. Anche se tratta di argomenti differenti e risente della passione politica utili suggerimenti sul tema si trovano in C. Ginzburg, Il giudice e lo storico, Feltrinelli, Milano
[9] Nello stesso tempo ogni difesa in favore dell’archivio rimarrà in sospeso, nella misura in cui non sappiamo se il passaggio dalla testimonianza orale al documento d’archivio è, quanto alla sua utilità o ai suoi inconvenienti per la memoria, rimedio o veleno. P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano 2003.
[10]Cfr A. Portelli, L’ordine è già stato eseguito, Donzelli, Roma 2005. Il libro offre una interessante panoramica dell'avvenimento, della sua percezione da parte dei testimoni e delle generazioni successive.



Commenti